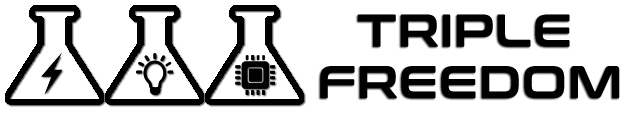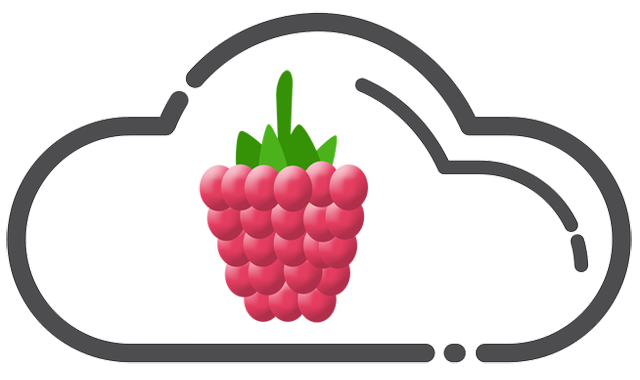SULLA LEGITTIMA BREVITA’ DEI TERMINI ISTRUTTORI PER IL RICORRENTE NEL RITO DELLA FAMIGLIA
20/10/2025L’ASSEGNO UNICO PER IL NUCLEO FAMILIARE AL CITTADINO STRANIERO
26/10/2025Al termine di una relazione affettiva spesso ci si trova ad affrontare tematiche relative agli esborsi reciproci o unilateralmente sostenuti da un convivente nei confronti dell’altro durante la convivenza.
Nella maggioranza dei casi, non foss’altro per l’entità della posta in gioco, non di rado la questione maggiormente rilevante risiede
sulla sussistenza o meno di obblighi restitutori nel caso, assai comune, in cui un coniuge o partner abbia versato nei confronti dell’altro somme per il pagamento dell’abitazione adibita a casa familiare, ma intestata all’altro.
Sul piano giuridico, la questione sta nel chiarire se il versamento di somme a tale titolo possa essere qualificato come arricchimento senza causa, con conseguenti reciproci diritto ed obbligo di restituzione, o, viceversa, come adempimento di obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità di esse.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità conferma il proprio orientamento secondo cui i versamenti di denaro che un convivente destina all’altro all’interno di una relazione affettiva stabile costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034, I comma, c.c. e pertanto non danno luogo ad obblighi restitutori.
Tuttavia nel contempo attua un temperamento di tale principio, specificando che esso si applica nei casi, da verificarsi nel concreto, in cui il Giudice di merito constati, all’esito di un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l’attribuzione fatta in costanza di convivenza sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
Quando invece le dazioni superino tali limiti può ricorrere il principio generale dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c..
In sostanza, l’ingiustizia dell’arricchimento si palesa e l’insorgenza degli obblighi restitutori può conseguentemente concretarsi solo allorché si sia in presenza di prestazioni patrimoniali che superino i confini dell’assistenza materiale che normalmente ci si attende in un rapporto di convivenza, tenuto delle condizioni patrimoniali della coppia in esame.
Con la pronuncia n. 11337/2025 la Corte di Cassazione Civile ha rilevato che la Corte d’Appello che aveva ritenuto in secondo grado l’insussistenza di diritti alla restituzione nella fattispecie esaminata aveva valutato che il convivente, unico percettore di reddito nella coppia, aveva versato 24.000,00 euro in tre anni per le rate della casa di abitazione in cui entrambi i membri della medesima risiedevano e che, quindi, l’importo medio versato di circa 666 euro/mese fosse – sulla base del notorio – all’incirca corrispondente ad un canone sul mercato locatizio e pertanto adeguato alle sue possibilità economiche.
La Suprema Corte ha pertanto confermato la decisione della Corte del gravame, specificando che spetta a chi agisce ex art. 2041 c.c. per la restituzione dare prova dell’avvenuto esborso, ma anche dell’insostenibilità della dazione rispetto al proprio patrimonio.
L’attore aveva invece documentato buste paga da 1.700,00 euro mensili, ma non aveva dato prova dell’assenza di altre fonti di reddito, e la Corte distrettuale aveva finito per escludere l’esistenza di uno squilibrio ingiustificato tra esborsi e possibilità economiche dell’istante.
La richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, così come le altre precedenti che hanno seguito il medesimo orientamento (v. 14732/2018 e 11303/2020), ribadisce un principio consolidato che, lungi dall’avallare una automaticità degli obblighi di restituzione per le elargizioni in corso di convivenza per il titolo esaminato, tutela la stabilità e la coerenza nelle relazioni affettive tentando di evitare una rilettura posteriore delle medesime in chiave, in senso stretto, patrimoniale.
Con la conseguenza che solo dove emergano, dopo un attento esame da svolgersi in sede di merito, squilibri tanto gravi, documentati e privi di giustificazione alcuna, che si rivelino tali da fondatamente ritenersi la necessità di intervenire sul piano giuridico per ricondurre le due posizioni degli ex partners ad equità, è possibile che l’azione di ingiustificato arricchimento – che è azione residuale nel nostro ordinamento giuridico – possa essere accolta.